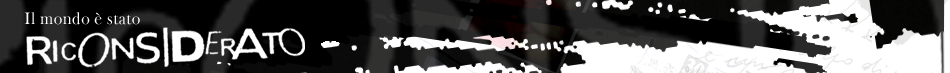|
Poesia lineare
Abbozzo di autoritratto | Il diluvio dice | Leopardo | Lo spazio irriconoscibile | da La Transilvania Liberata | Luce bambina
Abbozzo di autoritratto
Nel grande circo
volteggia in sella a una bici candida.
Ovunque fuoco segreto orla ali
stellandogli il corpo che sfida la logica
degli eventi.
Fuoco bianco al culmine
del mutamento insaturabile (blank!),
kairòs, urlo fragile (s’ingiglia
la montagna dell’Ararat)
incenerisce
anni di vita annidati nel fulmine.
...
...
...
...
«Racchiuso nella luce
del Tuo sguardo d’angelo
il cosmo sfolgoRa»
(Il libro dell'angelo, 1991)
su >>
Il diluvio dice
Potenza degli oceani percorre
i boulevards dell'anima
e i venti sibilano
nomi oltre le mura rosso-oro
dei labirinti.
Onde straripanti
spianano massi colossali
a gloria delle fonti dell’abisso.
Precipitando dal cielo, battuta
dalle piogge, pietra, nume ferito
dalla luce, sanguina
fiamme a forma di colomba: volano
là dove il diluvio
dice un’arca di parole.
(Il libro dell'angelo, 1991)
su >>
Leopardo
Leopardo stregato
sotto le ali coperte di brina
del corvo, pànico del nottambulo
in cerca di una ragazza torva,
si strofina il mantello
- eletto alla risonanza delle pléiadi -
contro l’abside della cattedrale.
lnviato per evocare l’origine
della luce, sette volte dal gorgo
accecante risale
al centro delle pupille contratte.
Conduce al crescendo implacato
nel tremito del primo
fulgore astrale.
Nelle vetrine impudiche dell'alba
appare a oriente,
inizia l’anima
al terrore della perfezione.
(Il libro dell'angelo, 1991)
su >>
Lo spazio irriconoscibile
1.
L’aquila reale s’interna nel cuore
leso del silenzio. Ali spietate
sprofondano nella polvere d’oro
delle parole abrase.
Romba il silenzio che rincasa nello
Spazio irriconoscibile.
2.
Si spengono le ali
dell’aria. L’inverno
sarà eterno. Nella muta leggenda
del tuo corpo volubile tenebra
non inceppa il fulmine.
S’incenerisce inattesa parola
sul culmine spezzato a distanza
impercettibile dal nulla.
3.
I passi affondano in perni di nebbia.
L’inverno a stento conferma abitudini
sottraendosi alla figurazione
del vortice.
Il cuore d’argilla si disperde
in forma di raggi luminosi
se il nulla sorge dall'epicentro
delle cose.
4.
Lo spazio pietrifica
cose che mutano senza passione.
Ruotano alterando il silenzio
della Via Lattea
in tetra gabbia di ghiaccio invisibile.
Agonìa si dissolve se appare
aquila nel calice di fuoco
in espansione continua
sulla soglia effimera della tenebra.
5.
Trema il cielo se l’oceano in collera
assume la forma del falco: in cima
a guglie d’acqua salmastra e di ossa
frantuma lastre di cristallo, schiude
voragini nella scia sonora
che solca l’aria; dirime diafane
corolle, gigli di spuma; fuori
dal tempo si dilata
pupilla nel ventre dell'abisso.
(Il libro dell'angelo, 1991)
su >>
da La Transilvania Liberata
( 1985 – 2004)
PROLOGO
Io canto l’aquila in volo
prima che fossero creati i cieli;
canto il volo che figurò nel vuoto
l’albero e i rami innevati
prima che sorgesse monte a presidio
delle piane frustate dall’uragano.
Le tempie brizzolate nella furia
dell’estrema stagione amorosa,
canto il sangue vermiglio
come il sole che sorse in principio
dissolvendo la tenebra compatta
nella gloria del primo mattino.
Canto il fiume che scorre da sempre
oltre le barriere dello spazio
e varca il gorgo luttuoso del tempo
allorché il cosmo fragile dell’uomo
s’inabissa nell’orbita del teschio (1),
titanica dimora dell’anima.
(Non canto la notte cieca
del trafficante su di giri
insensibile agli sballati trafitti
dalle luci delle città orgogliose
e troncati nell’immondezza).
Nel fragore delle grandi acque ascolto
la voce sublime di Torquato Tasso
la cui eco scaccia dalla mente
il superfluo e trasmuta l’anima
nell’austera, solenne e risonante
cattedrale della fede poetica.
Indosso una tunica di lino
e vedo una schiera di cherubini
dilatare la cenere dei sogni
a immagine della volta stell
dove Urania (2) enumera i nomi
dei defunti capitani magiari
e canta le gesta di chi visse
combattendo per la Transilvania.
La mia voce ritrova i corpi astrali
e tra le nuvole innalza rovine
e frantuma monumenti dell’invasore
e i suoi resti esclude dal visibile
perché solo davanti agli oppressi
si spalanchi il portale del tempio.
Io canto il coraggio che unisce
cielo e terra e seguo l’aquila in volo
verso il cerchio cocente del sole
per plasmare con l’argilla del fiume (3)
che scorre oltre i gorghi della morte
il Dio portentoso invocato
da chi combatte per la bellezza
e per il bagliore delle origini.

Note al Prologo
(1). La preistorica religione magiara colloca nel teschio la sede dell’anima dei defunti.
(2). La Musa della Gerusalemme Liberata è Urania (Cf. Canto Primo, Stanza 2, “…tu rischiara il mio canto, e tu perdona/ s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte/ d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte.).
(3). Il Demiurgo, secondo la Genesi magiara, appare in forma di un’aquila che tuffandosi nel fiume dell’eternità ne emerge con della sabbia o con l’argilla con cui forma il mondo
dell’uomo. Cf. Ipolyi Arnold, Magyar Mythologia, Pest, Heckenast Gusztàv, 1854 |

CANTO 1
All’interno della macchina ferma
s’accende luce fredda :
un giovane in maglia bianca fuma
e legge il giornale: nello specchietto
retrovisore ogni tanto appare
una ragazza in camicia da notte
rosa, preme all’ orecchio
una piccola transistor:
“…ascoltate chi abita questo muro
di pietra, monumento alla città
che dorme nel proprio nulla…”, recita
una voce non impostata e rauca
“…resi arroganti dal vino, i guerrieri
nelle armature risplendenti
partirono per non tornare,
e la città, opera di giganti,
sotto la prepotenza del nemico
divenne un ammasso di rovine
fumanti intorno a questo
meraviglioso muro
di pietra che racchiude
il passato nel grembo…”.
Una forma bianca, un giavellotto,
con la punta d’acciaio
vola a infrangere l’obiettivo;
da improvvise sventagliate di luce
illuminato il poeta rifiuta
di sintonizzare l’apparecchio
all’interno del muro
con il transistor della ragazza
in rosa, la sua voce riempie
di fiamme i cieli.
“Mi ridestai sulla rupe lucente
a picco sull’Atlantico colore
dell’inchiostro. Oltre la cintura
di vapori tetri, la furia
dei marosi assediò il mio cuore
travolto dall’impeto
dei flussi contrari; turbinò il sangue
nelle vene flagellate.
Dal tumulto dei venti e delle onde
risucchiato, sussultai nella tenebra
che bolliva e ruotava sibilando
per vortici in cui franavano monti
d’acqua salmastra. Di colpo apparve poi
una calma ignota:
come annegato, mi sentii spinto
in riva al cielo crestato di bianco.
Grandi ali tese di procellaria
sfiorarono la superficie
dell’oceano. Nella luce del mondo
nuovo vidi il colosso di pietra
che nella mano sinistra sorregge
la tavola dell’indipendenza nazionale
e con la destra alza verso il cielo
la fiaccola della libertà.
93 metri di miraggio
precipitarono nel cielo acceso
di collera poiché la libertà
sfiora solo di rado
la terra, forse solo
quando chi l’ama alla follia non sa
più vivere senza battersi per lei.
Io a Budapest non c’ero (1) a salutare
con il mitra al cielo alzato
la ritirata dei carri armati,
né alla luce fioca dei lumini
m’inginocchiai sulle tombe
dei patrioti; non c’ero
(da tempo in occidente)
a battermi per l’indipendenza
reale,
né accecai col fango il periscopio
dei carri per aprire la via
ai molotov dei compagni.
Né ornai il braccio col tricolore
della Guardia Nazionale, né vidi
a tradimento i Russi seppellire
in una colata d’acciaio il grido
di libertà che salvò un popolo
intero dal disonore.
Non fui arrestato, interrogato,
bastonato, inumato in catene.
Ma sono ancora qui ad ascoltare
la voce dei soldati
che in un altro novembre
sfilarono sotto le finestre
della dimora paterna cantando
‘Dolce Transilvania, da Te veniamo,
per Te viviamo, per Te moriamo’ (2).
Scalino dopo scalino raggiunsi
la corona del colosso a strapiombo
su di una scogliera paurosamente
nera: girava su se medesima
cinta da un diadema di nuvole
luccicanti di schiuma.
Dal fondo irto di rocce aguzze
ascese la candida voce di giglio,
la pronuncia selvatica di Fleur (3),
gloria vivente del genio poetico.
Voce incontenibile,
sgorgò a diffondere nella mia mente
senza tregua lo sguardo
dell’uragano. Su di me zampillò
acqua tanta quanta i miei capelli
e vesti vaporose
poterono assorbire.
Arsi nell’azzurro; parlò il vento,
parlò l’acqua; salmodiò il fuoco
mentre il bosco pauroso
sognò nella lingua dei violini
la grazia dell’infanzia.
‘Rischiara il mio canto,
rendi più lieve
questa impossibile fedeltà’.”
Il giovane uomo in maglia bianca scende
dalla macchina e le braccia sventola
in direzione della ragazza
in camicia da notte rosa: essa
gli sfreccia attorno del fieno in fiamme
lanciando in memoria
della bellezza barbara
del Re che senza consumarsi arde.
Al di là del fiume
palloncini vermigli
volano in cielo, mentre mille ventri
di plastica gonfi di vernice
si fendono, liquido purpureo
spargendo su i due scalmanati
avvolti nella tiara lunare:
addio, cadono sul selciato, inzuppati,
dei corpi dissanguati
sembrano di lontano.
“Gli uccelli della risacca si tuffano
al bruciare delle ombre”,
così Fleur, prima della dissolvenza
che porta verso l’alto.

Note al Canto 1
(1). Al tempo della Rivoluzione Ungherese del 1956.
(2). L’autore, nella sua prima infanzia, assimilò il sogno magiaro della riconquista della Transilvania (terra madre di poeti ungheresi come Ady Endre, di musicisti come Béla Bartok), assegnata alla Romania dopo la Prima Guerra mondiale.
(3). Fleur è la Musa inattesa. S’impossessa della voce del poeta durante un suo viaggio nel “nuovo mondo” (1985). |

CANTO 4
Sgorgano dalle nuvole serpenti
dal tuono intorti nella corona
la fronte fulgente di rugiada
serrando, nella morsa assordante
i neri capelli, fiumana
di vocali elisie, rivoltando,
fremito all’interno della luce
da cui scaturisce
il canto delle levatrici del mondo.
Armonia inaudita, Edith (1),
tra conoscenza e amore non sceglie,
il suo spirito vibra nella siepe
della goccia di sangue
e ripudia l’abisso
che si disvolge decrepito
per attorcigliarsi intorno al globo.
Non è mai salita tanto in alto,
al di là di ogni forma
vivente, il suo sguardo
scorre sul mondo come oceano
che restituisce i morti.
Il sole è una piaga di fuoco
nella foresta di lacrime dove
l’uomo caduto
si perde nell’aurora.
“Cara Anyu (2)”, soave madre, cantami
ancora la pianura
profumata di timo,
lontana e fragrante
del latte delle cavalle di fumo
e di vento, la tenda del Principe
al di là della Montagna di Vetro,
l’ardente coro degli sciamani,
i sette sigilli che garantiscono
il vero al di qua dei boschi d’oro,
i rosolacci che sbocciano liberi
al grido del querceto focoso…”.
Leviatani alzano
la criniera e i libri
di bronzo e di oro si fondono
nella consumazione
segreta dei simboli
finché l’anima di Edith
notturna non rinasce
nel cerchio della perfezione
tracciato sul vuoto in espiabile
delle origini (3).
Rumore gelido e senza figura
occulta ora la polvere
che fu un popolo unito;
rumore precipita
sulle dimore deformate
dall’oppressione, mura
nelle fenditure del terriccio
tremano seminando
disonore nel cielo stellato.
“Non temere figlio per gli avi
dal volto di metallo, sepolti
nel cerchio dello spettro
lunare;
osserva il loro capo
nella pietra celeste scolpito,
il loro corpo in dardi incatturati
oltre le nubi teso. Fissa
lo sguardo in approdi abbaglianti
in case redente
da ogni umano abominio, poiché
dovrai crescere più forte di Bulcsu
che in cima a una picca
sul terrapieno di Cambrai
vide la testa del fratello
e sommuovi con il pensiero
il cosmo intero siccome con Léel
e Sur (4)
nel cerchio dentato del capestro
è appeso a Ausburg.
La tua ombra separata dal corpo
e dal vorace nulla, fluttua
nel calice della rosa tremante
nutrita dalla prima rugiada
dell’aurora, ma altro libro
non leggere
che quello più alto della polvere
transilvana: esso ti vincola
ai vivi e ai morti
e a coloro che ancora nasceranno
nel mese dell’aquila (5)…

Note al Canto 4
(1). Edith è la madre del poeta, morta a Milano il 27, VI, 1989. Ora Edith Gero Barca si trasmuta in una divinità transilvana arcaica.
(2). “Anyu” è diminutivo affettuoso di “Anya”, termine ungherese che significa “Madre”. Qui viene invocata da Vajk, un guerriero magiaro del IX secolo, ma che ricompare in varie epoche nel poemetto.
(3). Si allude alla misteriosa maledizione che colpì le tribù magiare quando varcarono gli Urali in tempi preistorici.
(4). Nell’anno 948 Bulcsu, Lèel e Sur, richiesti di chiarire le loro identità, risposero all’imperatore di Bisanzio “Nos sumus ultio summi Dei, ab ipso vobis in flagellum destinati” (“Siamo il castigo del Dio superno, da Lui medesimo destinati ad essere vostro flagello”). Misero il mondo a ferro e a fuoco. Bulcsu fu sgomento solo quando scorse la testa tagliata di suo fratello su una picca (siccome per i magiari la testa è la sede dell’anima immortale). L’imperatore Ottone I li sbaragliò nel 955.
(5). “Il mese dell’aquila” è marzo. L’anno per gli antichi ungheresi iniziava all’arrivo della primavera. |

CANTO 9
Le ali dell’aurora di polline
aurato velate, scorrono
su croci di latta e erbe selvatiche
bruttate di sangue.
Il fiore falbo dell’asfodelo
langue insieme alla rosa.
In fondo al cimitero
nove giovani corpi tumefatti
giacciono uno accanto all’altro poggiati
sul cemento scrostato
di un’umida cella,
i piedi uniti da un filo di ferro.
I loro compagni d’armi sbandati
correndo sulla strada polverosa,
sorvegliano con lo sguardo l’azzurro
delle paratie blindate,
lo sfolgorio delle fusoliere,
l’ampia carlinga degli Sturmovik (1)
che li serrano da tergo
in picchiata e a volo radente.
Per i quasi inermi la via s’oscura
al fuoco latrante di mitragliere.
Sulla piana butterata da raffiche
scorre il sangue putrido dell’agnello
a dissetare i demoni
scheletriti del crepuscolo. Thor (2),
nello sterminio intrappolato,
disdegna la lotta,
colto di sorpresa
dall’avanzare dei carri volanti
il martello di Mjolnir (3)
abbandona nel brago, e le insegne
della morte insaziata
onora a cavallo.
Il fiore falbo dell’asfodelo
langue insieme alla rosa,
la disfatta ingloriosa
oscura la via ai male-armati
e chi s’immola furioso,
chi si raggomitola in una roggia
e chi in una fossa si getta.
Vajk stringe la spada orgogliosa
nella miseria estrema rovinando
all’abbandono
del decrepito Dio della guerra.
Trafitto da una scheggia
vede angeli tra le nubi
rischiarate dallo sguardo di Edith (4).
Si spalancano le porte dell’aria,
prorompono leoni di fuoco
e la sua anima si libra
in un gemito volta in aquila chiara.
Obliando le acque del Danubio,
del Tisza, della Drava e della Sava
gli Oceani del tempo
trasvola finché gli appare una costa
rocciosa e alta. Sulla vetta
di una balza petrosa
col ruggito di una leonessa eterna
Holda (5) tra le fiamme
della nascita nuova gli alita
nel seno l’energia ignota
che all’acrocoro lo avvince.
Smisurata pena l’occhio gli dilata
nella cattedrale ardente
dell’etra. I visi dimenticati
dei fanti dell’Armata devastante
della devastante Armata Rossa
tornano in un miraggio da incubo
come le maschere innumerevoli
del massacro e del terrore:
i superstiti nelle case sventrate
assistono immobili
al saccheggio dei beni familiari
e le inermi stuprate
vagano nella notte
lasciandosi trascinare dal flusso
dei lari dispersi.
Dentro il vuoto senza casa né tomba
Vajk affonda nello scorgere Piroska
scendere dallo specchio nuziale
e sotto la minaccia di un mitra
puntato alla gola, cedere
a chi in divisa nemica le gode
le membra stellari.
“Una belva che le divora il cuore
nella selva del piacere più vile.
Il suo corpo fedele
tradito dalla vita,
la sua bocca ferita,
la siepe d’onore dei suoi occhi
che non celano un’ombra di follia,
la curva dei suoi seni ricomparsa
sull’erba dell’infanzia perduta
snudata su paglia d’astri
la sua fronte pallida e alta
che i sogni non più serba…”.
Così Vajk si dissangua
nella luce riflessa
del lutto accecante.
Il coro degli Antenati lo scorta
nell’aria opaca d’ira
riportando parole del diluvio:
“Gli astri supremi sferzano i venti,
l’Auriga e Orione riversano mari
dalle urne gemelle colmando le alte
navate dell’ètra. Onde smisurate
infrangono il tiburio flagellando
la cupola celeste:
così l’universo colpisce i cieli.
Le acque scorrono argini e rive
soverchiando; il fiume più grandioso
del Settentrione si mescola
col Tisza, la Drava, col Maros
dapprima coprendo valli e piane
investendo poi luoghi più elevati.
Emergono ormai solo
le vette dei boschi agitate
da sempre più rapide correnti
e dal mulinare dei venti. S’alzano
in volo uccelli raggiunti in breve
da flutti e frangenti che li cacciano
più su. Fuggono bestie selvatiche
per essere inghiottite dai gorghi.
Un enorme tonno esplora la tana
del cinghiale e il capitone
s’attorciglia nel covo della lepre
dalle lunghe orecchie. Il gambero
si rintana nel nascondiglio
della volpe dagli occhi obliqui
e i pesci depongono le loro uova
nei nidi degli uccelli.
Non sanno più dove riparare i magiari;
slavi e germani s’innalzano
come flutti. Svaniscono i villaggi
città e campi, si dissolvono i monti
sommersi da un deserto
di acque infuriate”.
Il Dio Danubio interrompe qui il Coro:
“E’ il flagello
che colpisce i magiari a destare
parole che cantano
il giorno interminabile
che precede l’esodo dei popoli
dai paesaggi dell’odio
e della sopraffazione,
parole che preferiscono
l’’estinzione dell’uomo
all’eterna ingiustizia del mondo,
parole che annunciano la rivolta.
E’ il flagello
a riportare il verbo in terra
perché appaia un Messia Magiaro,
un intero popolo crocifisso.

Note al Canto 9
(1). Sturmovik fu il nomed del più celebre e miglior apparecchio usato dalle
forze aeree sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale.
(2). Divinità del tuono.
(3). Martello meraviglioso.
(4). Madre di Vajk.
(5). Dea che favorisce la difesa della Natura e dei singoli popoli e culture. |

CANTO 12
Dalla cenere delle parole
in splendenti armature sorgono
soltanto ombre di guerrieri al centro
della città costruita da giganti,
muro di pietra lucida
da un ammasso di rovine serrato,
muro di pietra che nel grembo
racchiude il passato.
Invano i riflettori illuminano
la distante vetta montana;
nell’indistinto bianco
non vi è luogo per figura umana;
nel vuoto lancinante
del tempo spalancato
risuonano voci scaturite
dalla pietra e dalla ferita orrenda:
“Sontuosità della carne felice…
Eva è madre dell’umanità,
madre
del popolo è la guerra di liberazione…
brutale grandezza di nebulosa
luminosità colossale dei cieli…
non ti sei sciolto
ancora nel canto
se guardi le stelle
come
prede di luce,
canto che resiste al ferro e al fuoco,
all’ira degli Dei
e al tempo che tutto consuma…”
“Cosa vedi Fleur?” “Vedo
la lunga via che da Etelkoz
porta le tribù magiare a Erdèly
nome sacro della Transilvania
dove inizia il sogno
e inizia il poema”.
Ma il cantore incurante
dell’orizzonte, gioca
con barattoli di latta e danza
al crepitìo dei rifiuti in fiamme.
Al lampo verde-sporco, adirato
si gira verso gli altoparlanti in cima
ai pali piantati in ogni direzione:
“Tu che ti occulti in nubi
di polvere giallastra
e nel fetore dei detriti taci,
col tuo silenzio atroce
l’aria, l’acqua e la terra
contaminando o col trionfo del fuoco
le case degli inermi devastando…”.
Nuvole di cottone
appese a fili azzurri
vibrano nelle orbite
di soldati tornati a casa ciechi.
Una figura incoronata di spine
ascolta il battito nero dei cuori.
“E’ solo una comparsa,
non pronuncia una battuta “,
sussurra una voce molesta.
Crollano gli imperi
castelli di carta e di sabbia,
e il massacro degli innocenti
continua mentre l’anima del mondo
si consuma in gabbia.
E il bardo girovago,
da un appetito saturnino preso,
osserva la propria opera incompiuta
dissolvendosi in una scossa
che sazia il sangue dorato
delle stelle.
E si sente come un vecchio Cristo
deposto finalmente tra le braccia
della sua Madre Santa.

Nota al Canto 12
(1). Etelkoz si trova nell’Ucraina meridionale. Da qui iniziò, nel IX secolo d.C., la ricerca magiara della terra patria. |

EPILOGO
Non vi fu Dio a tuonare dai cieli
quando alle porte dell’inferno trovai
disseccata l’aquila in volo
prima della creazione del cielo.
A lungo vagai tra sterpi e paludi
finché fui dallo sconforto pervaso
e dall’insorgente senso del nulla.
Vidi le Muse convertirsi in corvi
e la mia voce udii gracchiare
nel silenzio di un campo di battaglia,
di incruenti scontri tra larve serrate
nell’affanno di ripetere gesta
ogni volta motivo di dolore
per gli eredi della disfatta. Tutte
le genti oppresse o disperse lo sanno;
non basta l’acqua piovana nell’orma
del lupo, né le acque di cristallo
e di vetro nei pozzi fragili
del serraglio lunare a dissolvere
in un istante secoli di pena.
Ma dall’acqua lustrale sull’altare
di Stefano il Santo (1), salpano flotte
le menti disancorando nel blu
regale. Fu Petra la maga avida
soltanto di gloria a disserrarmi
le voragini terrestri e le vie
dei cieli, perché io rivivessi
ciò che altrimenti restava incompiuto.
Io canto senza fine il dolore
degli sconfitti, il sangue avvilito
e la lingua in rovina; né servile,
né altero, come foglia che cade
scisso per sempre dal ramo. E anche
la notte precipita con Vajk (2),
il messia magiaro e il poema
brucia interminato tra le sue mani
volte al tempio del sole.

Note all’Epilogo
(1). Stefano I, Re d’Ungheria (969 – 1038 d.C.)
(2). Si veda il Canto 12, vv.70-73. |

(La Transilvania Liberata , 2005)
su >>
Luce bambina
Che cosa ne sapete voi della sofferenza di chi ha perso il “parlar materno” e nella maturità teme di non potere dire come il Brunetto dantesco “…il mio Tesoro / nel quale io vivo ancora…”. Io sono nato morto e scrivo per lo più in lingua morta e ciò avviene nonostante ch’io sia uno dei rari contemporanei a bruciare al fuoco sacro dell’entusiasmo poetico.
Da bambino sentii sotto la finestra della casa paterna la truppa magiara cantare “Edes Erdely itt vagyunk!Per te viviamo e muoriamo!” E sono quasi tutti morti davvero. E io ho scritto un epos La polvere d’oro della Transilvania perché mi ossesionava “Erdely aranykora”,che la catastrofe storica ha ridotto in “pora”.
Cosa ne sapete voi cosa significhi per un bambino la sconfitta definitiva del suo paese, la morte del padre e la sua terra stuprata dagli eroi dell’Armata Rossa? Seguì l’inevitabile fuga-esilio,con la mia anima sublime in subbuglio come una bandiera a sfidare la puttenesca inconsistenza della vita. Per decenni non feci che scorrere incontro al verso assoluto,senza riuscirvi, cercando il sacro fluire del mito babelico sotto il linguaggio.
E sono grato a Cesare Segre che nel saggio “La questione del verso”(Poesia,41,1991) ha focalizzato il mio contributo alla poesia italiana nella forma del decasillabo.Il verso quantitativo magiaro lascia la scena della mia pagina a distici decasillabici come “Ciglia di luce tenera inaurano/il serpente attorcigliato al cuore”, in cui mi riconosco in pieno.
Sedotto dall’endecasillabo a maiore del Petrarca (“erano i capei d’oro a l’aura sparsi”), dall’endecasillabo a minore di Dante (“mi ritrovai per una selva oscura”),ho trovato nutrimento negli anapesti del Manzoni (“tutti assòrti nel nuòvo destìno”) e nel doppio quinario del Carducci (“Oh quei fanali come s’inseguono/ accidiosi là dietro gli alberi”) e ho finito per contaminare di energia barbara il decasillabo, ritenuto esangue nelle scuole.
Tornando in aereo da un “reading”negli USA, scrissi Icaro (incluso in Recitativi in rosso porpora,Udine 1989), testo di cui riporto l’ultima stanza
Ai tempi del non si vede più nulla
cade, esclamativo bianco, putipù
(“ora le do i particolari opportuni”): ghiaccioli
a ore nel frigorifero dell’anima, corone
di neve a Roma; New York si scioglie;
perduta nell’aria s’addormenta luce
bambina
dove “luce bambina” non è che il mio “parlar materno”, la mia lingua madre, mai cresciuta, rimasta analfabeta, senza voce e pura come solo gli angeli sono, qualche volta.
(Recitativi in rosso porpora, 1989)
su >> |
|